Sappiamo quanto fugaci e magnetiche siano le ondate dei fashion trend, e quanto eccellenti siano le grandi aziende nel catturare la moda del momento. Le stesse industrie tendono ad annientare il valore di ciò che stanno mercificando, affaccendate come sono nel commercializzare ciò che i compratori, trasformando così l’approvazione della massa in ritorno economico.
Puntando su queste strategie di vendita, un po’ per mostrarsi inclusivi, e un po’ per lucro, diverse aziende spingono sul merchandising arcobaleno, soprattutto nel periodo che precede il Pride, in cui si assiste alla massima diffusione di quello che viene definito rainbow washing.
Questo processo avviene ad esempio con i marchi che hanno un target ampio, spesso di fascia low-cost. Nonostante la produzione di t-shirt con dettagli arcobaleno o simboli di Venere sembri appoggiare la causa queer, in realtà le multinazionali non fanno che riempire le proprie tasche, facendo leva su un’intera comunità, ricca al suo interno di sfumature diversificate, con l’intenzione di uniformarla, piazzando in modo seriale «Love is love» su milioni di borse di tela.
Se la replicazione industriale è una forma di mortificazione, lo è ancor di più il fatto che queste iniziative non sostengano realmente la comunità LGBTQ+, e che il profitto arrivi alle spalle delle vittime di marginalizzazione, violenze e atti di bullismo.
In questa profana compravendita, la celebrazione delle persone queer attraverso l’abbigliamento è nullificata, in quanto il linguaggio visivo che determina il proprio riconoscimento all’interno di una determinata comunità, entra a far parte della moda mainstream. Questo passaggio sottile, vanifica un codice del vestiario che trasuda simboli di lotta, di rivendicazione dei diritti e di storia.
Si verifica, quindi, una vera e propria appropriazione culturale per cui – in questo caso – un capo d’abbigliamento viene denudato del suo significato queer, per essere messo addosso ad una massa omologata, cancellandone la storia e rendendo quel capo un trend, solo perché esteticamente attraente.
Questo tipo di fenomeno è ben visibile in quello che è il trending of lesbian clothing. È passato poco più di un mese da quando il New York Post ha pubblicato un articolo dal titolo invalidante: «‘Dressing like a lesbian’ is sexy, ‘powerful’ new trend, fashion expert says». Ciò che si legge subito dopo il titolo è «Lesbi-honest, queer fashion is totally in!», una frase breve, ma che con un gioco di parole scadente banalizza senza porsi troppe domande la storia della moda lesbica. Si parla di una moda pronta per essere sfornata nel mercato, per essere riprodotta e venduta, finché quel “totally in” non verrà sostituito dal prossimo stile che andrà in voga! Cosa si vorrebbe intendere con “Vestirsi come una lesbica”? Non si tratta forse dell’ennesima oggettificazione?
Ellie Medhurst, una ragazza britannica e giovane storica di moda, ha commentato l’articolo ribadendo che non basta indossare un tailleur per vestirsi come una lesbica, a differenza di quanto più volte sottolineato nell’articolo del NY Post.
Look androgini e saffici sono diventati virali, da TikTok ai Red Carpet, e sono ormai disponibili in un qualunque negozio di fast fashion. Ma in tutto questo cercare di esaltare la moda lesbica, non si fa altro che promuovere nelle copertine il classico styling che rispecchia la normativa etero, il concetto basic di moda, e la depersonalizzazione degli abiti; tutto in netto contrasto con lo spirito della moda queer.

L’opinione di cui subisce in prima persona i risvolti di questo fenomeno è quasi sempre allineata: ne abbiamo parlato con Blerinë Shala, 23enne studentessa di design all’università di Firenze e membra di un collettivo pro LGBTQ+ kosovaro.
«Quando si pone la domanda “Che vuol dire il modo di vestirsi per te?”, credo più o meno che tutti diano una risposta simile a “Rappresenta il mio mondo interiore” o “Rappresenta in modo diretto o indiretto la mia personalità”, ed è tutto vero. Attraverso lo stile trasmettiamo dei messaggi alla società che ci circonda, e la stessa cosa vale anche per la comunità delle lesbiche. Il fatto di non essere state in grado di comunicare apertamente la nostra identità durante la storia, ha portato inevitabilmente le donne lesbiche a creare degli indizi e dei simboli anche nel modo di vestirsi. Sicuramente durante la storia questa forma di comunicazione è stata sempre alimentata e arricchita fino al giorno d’oggi, dove essa prende la dimensione di una cultura multi-creativa.
È un mondo prezioso e merita di essere trattato come tale. Lì riposano le lotte e l’ardente desiderio di libertà dalla discriminazione. Lo stile delle donne lesbiche non è solo un tessuto adibito a coprire parti del corpo, ma dimostra orgoglio, determinazione e coraggio di presentarsi in quei capi, nonostante il pericolo di poter perdere anche dei privilegi, perché non conformi alle aspettative del patriarcato e dell’etero normatività.
Ma a quanto pare ora la nostra bellissima storia sembra attrarre l’occhio del capitalismo e della commercializzazione. La nostra cultura, una volta usata come unico modo di comunicazione a prima vista tra donne lesbiche, ora si sta trasformando nell’ennesima avara contrattazione, dove il nostro stile, la nostra storia, si vende nei negozi ad un prezzo incoerente al valore, dove sarà accessibile a tutti, incluse le persone che non dimostrano rispetto e/o interesse nel voler conoscere da dove viene, e cosa significa ciò che compare nelle vetrine. E credo che quegli outfit non siano nemmeno disegnati e progettati da persone queer: più o meno si ripete la stessa storia del Pride month clothing commercialization.
Nei giorni di oggi, nonostante la libertà che c’è nel dimostrare il proprio orientamento, a me non fa piacere il fatto che non riesca a capire chi sono le altre lesbiche, oltre a me. Questo appropriamento sta desaturando anche l’orgoglio di portare quei dyke jeans… non hanno più la stessa esclusività: sono solo un altro paio di jeans. Vedere una rivista riconosciuta globalmente, uscire con un titolo del genere è incredibilmente brutto, oggettificante e sfruttante.
Quel “potere” che deriva dal lesbian fashion è potere, perché da lì derivano la perseveranza e la ribellione di migliaia di donne; non è cercare approvazione esterna per poter dare una certa impressione, quando in realtà si è in uno stato di impotenza e di mancanza di creatività. In poche parole, questo fenomeno è un’invalidazione totale verso il lesbismo.
È un puro esempio di come la maggioranza coglie le caratteristiche delle comunità prive di diritti civili a scopo di lucro, senza accreditare o addirittura riconoscerne i creatori. Se c’è una cosa che si deve insegnare ai bianchi privilegiati, piuttosto che alla generazione Z, è la differenza tra l’apprezzare e l’appropriarsi di una cosa, in questo caso di un’intera cultura.».
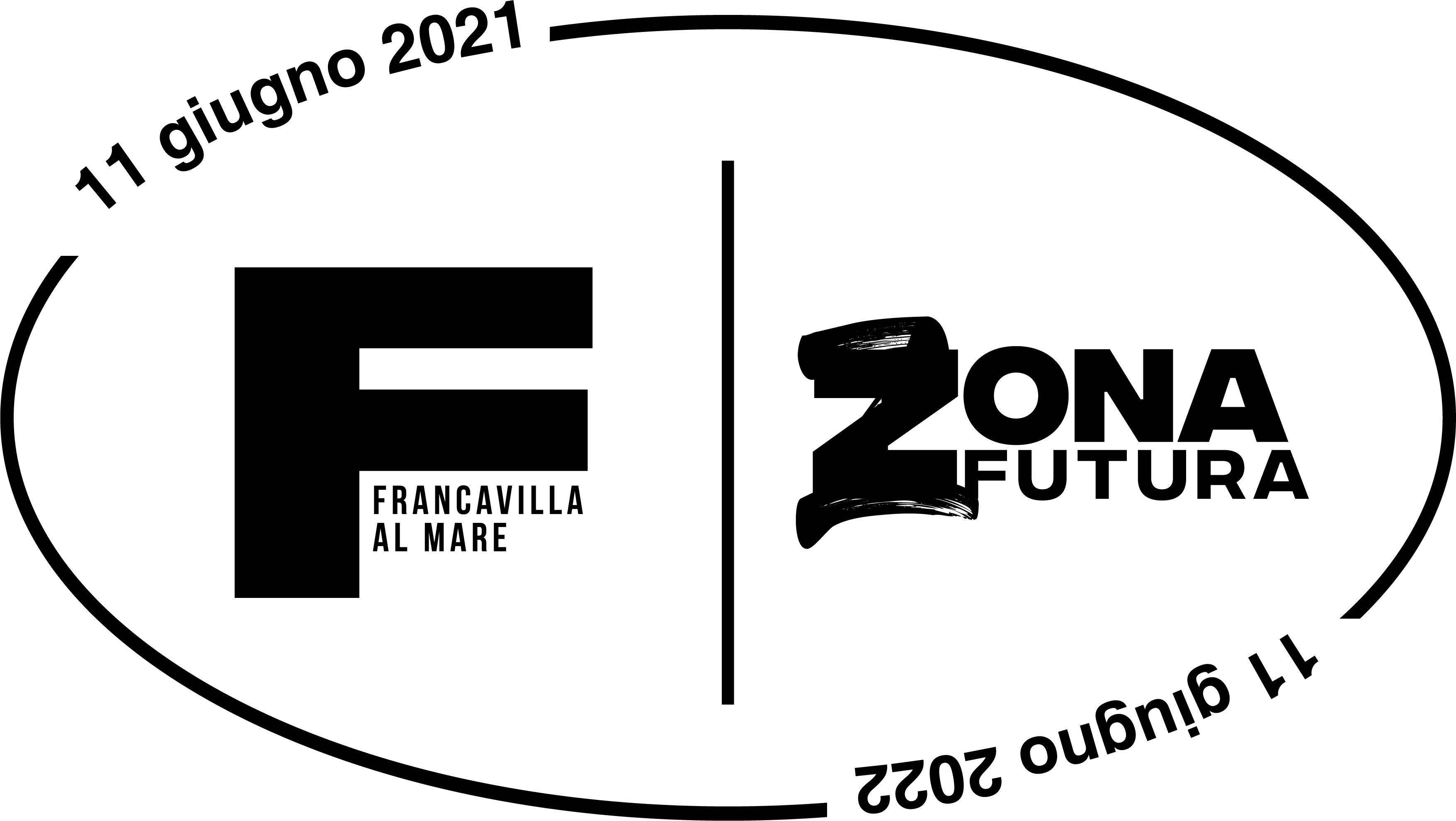
Perfettamente, non è merce l’identità di genere. Non funziona un tanto al chilo, nemmanco a cottimo.