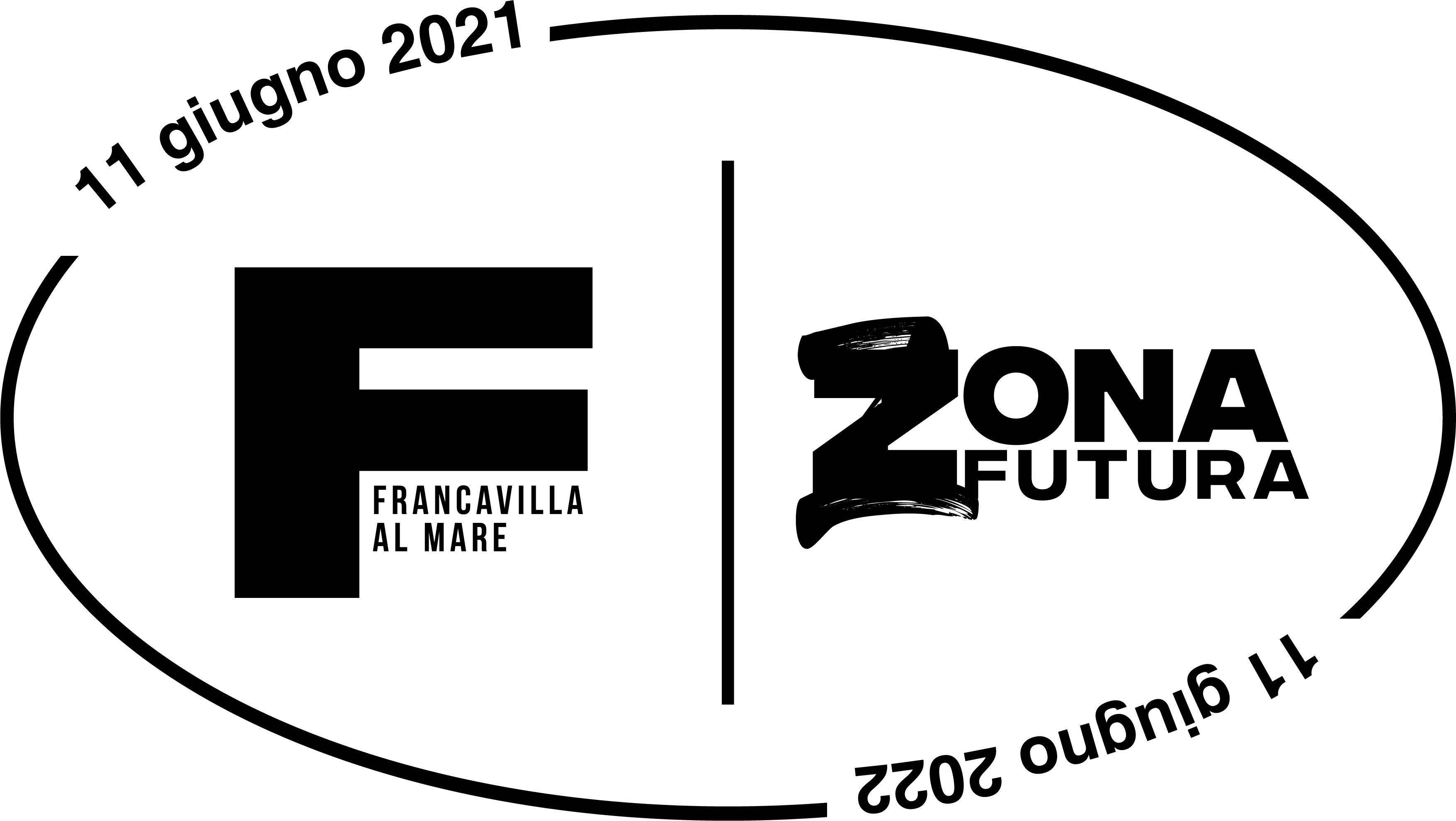La comunità Transgender, come già affrontato in altri articoli della redazione Arcobaleno, ha vissuto e vive tutt’ora delle discriminazioni che spesso possono essere ricondotte ad un’ignoranza culturale e scientifica sulla transizione. Lo sport, nelle sue infinite discipline, è sempre stato binario con una suddivisione di genere tra uomini e donne. Alla base di questa separazione differenze fisiche che portano ad avere performance atletiche dissimili.
Glossario Arcobaleno – Drag Queen, Drag King, Crossdresser, Transgender
Grazie ad anni di sensibilizzazione culturale e procedure mediche più avanzate la transizione non è più un tabù. In una società pensata per essere binaria, ci sono delle casistiche che non sono state prese in considerazione. Uno degli esempi più concreti e controversi riguarda i regolamenti delle federazioni internazionali dei vari sport, ma qualcosa si sta muovendo.
Il CIO – Comitato Internazionale Olimpico – da circa un ventennio – lentamente, ritoccando il protocollo prima nel 2004, poi nel 2016 – sta lavorando nella direzione dell’inclusività, con regole che non prevedono più esami per misurare il livello di testosterone o trattamenti invasivi. Attualmente esiste un decalogo che tra un paio di mesi dovrebbe diventare legge. In sostanza si dice che «chiunque, a prescindere dall’identità di genere, dal sesso e dalle sue possibili variazioni, ha diritto a partecipare alle competizioni sportive» e che «Nessun atleta, che sia uomo, donna o in condizione di transizione tra l’uno e l’altro sesso, potrà essere sottoposto a test medici che verificano il genere di appartenenza».
Ha fatto giurisprudenza il caso di Caster Semenya – che tra l’altro non è transgender, nel 2019. La IAAF – L’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera – aveva imposto alla campionessa olimpica sudafricana delle cure farmacologiche per ridurre il livello di testosterone, ma Semenya fece ricorso e portò il suo caso nelle aule di tribunale alzando il velo sulla questione e dando una «picconata» alle ipocrisie. La calciatrice canadese Quinn, nata Rebecca Catherine Quinn, medaglia d’oro con la squadra femminile a Tokyo 2020 è stata la prima atleta transgender a salire sul podio ai Giochi Olimpici; così come la sollevatrice di peso neozelandese Laurel Hubbard è stata l’apripista tra i partecipanti. In questo senso Tokyo – con i suoi 157 atleti LGBTQ+ – ha significato un grande passo avanti verso l’inclusività nello sport.

L’ultimo episodio in ordine cronologico si è aperto attorno alla scelta della nuotatrice transgender Lia Thomas. La storia è presto detta ed è simile – nel suo svilupparsi – a tante altre. Lia, 22 anni – atleta dell’Università di Pennsylvania – per tre anni ha gareggiato con la squadra maschile. Poi ha cambiato sesso, si è sottoposta a quasi due anni di trattamento ormonale, ha perso peso e massa muscolare, è rimasta ferma un anno causa pandemia e quando ha ripreso l’attività è passata alla squadra femminile cominciando a vincere trofei e diventando la prima nuotatrice transgender ad aggiudicarsi una competizione di nuoto agonistico nel circuito universitario.
Molte federazioni si stanno muovendo, non senza difficoltà. Controverso è il caso della FINA (Federazione internazionale di nuoto) che ha emanato le nuove linee guida che stabiliscono i criteri di partecipazione alle categorie maschili e femminili di tutte le competizioni ufficiali. Una decisione presa attraverso l’operato di un gruppo di lavoro creato nel novembre 2021, che sembra anche una risposta alle polemiche generate dalla partecipazione ai campionati NCAA della nuotatrice transgender Lia Thomas. Il gruppo di lavoro era così composto: un gruppo di atletɜ, anche trans, un gruppo di esperti in ambito medico e scientifico, un gruppo specializzato in diritti umani. La spinta progressista della FINA sta nell’annunciare la volontà di creare categorie aperte in cui è possibile partecipare e gareggiare liberamente a prescindere da identità di genere e sesso anagrafico, i cui criteri saranno stabiliti da un – ulteriore – gruppo di lavoro. Come scrive l’attivista Chià Rinaldi per La Falla del Cassero, se si vuole cogliere un problema non lo si trova nella «proposta di categorie aperte, quanto nella sua ragion d’essere: l’elenco di stringenti criteri di eleggibilità per la partecipazione alle competizioni sportive femminili, sempre al fine – intrinsecamente sessista – di proteggere lo sport femminile».
Il risultato dell’operato FINA è una vera assurdità che impone alle atlete trans e alle persone intersex (con una particolare variazione cromosomica considerata potenzialmente mascolinizzante) l’impossibilità di gareggiare all’interno delle categorie femminili a meno che non si rientri nei seguenti casi: a) totale insensibilità agli androgeni; b) la soppressione della cosiddetta pubertà maschile a quello che viene definito Tanner Stage 2 (cioè in una fase che va dai 9 ai 14 anni).»
A dirla tutta ci sono anche molte opinioni critiche sulla svolta inclusiva dello sport. Per citarne una su tutte, Joanna Harper, medico, sportiva ed autrice del libro Sporting Gender – The History, Science end Stories of Transgender and Intersex Athletes. «Le donne transgender», dice, «sono solitamente più alte, grosse e forti delle donne cisgender e in molti sport queste caratteristiche rappresentano un evidente vantaggio».
Se pensate che ci sia una risposta giusta vi sbagliate. Non esiste una soluzione universale e ogni sport ha delle peculiarità che andrebbero sviscerate. La cosa certa è che come ogni settore, anche quello dello sport deve affrontare il discorso dell’inclusività e dare delle risposte al passo con i tempi che non banalizzino una realtà sempre più complessa.